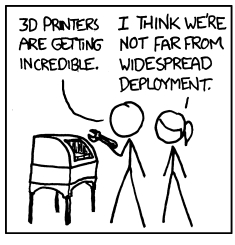 Lunedì 26 marzo ho organizzato un seminario su stampanti 3D e conflitto industriale. Johan Söderberg parlerà di:
Lunedì 26 marzo ho organizzato un seminario su stampanti 3D e conflitto industriale. Johan Söderberg parlerà di:
A factory for the kitchen table. New industrial conflicts in the social factory
infotech
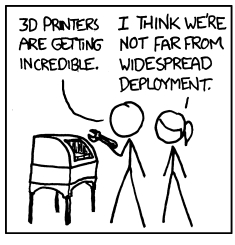 Lunedì 26 marzo ho organizzato un seminario su stampanti 3D e conflitto industriale. Johan Söderberg parlerà di:
Lunedì 26 marzo ho organizzato un seminario su stampanti 3D e conflitto industriale. Johan Söderberg parlerà di:
A factory for the kitchen table. New industrial conflicts in the social factory
 Centomila. Sono arrivati a centomila i clienti di 23andMe, l’azienda di genomica personalizzata di Google che da qualche anno si è messa sul mercato della genetica fai-da-te. Se sei preoccupato perché Facebook e Google sanno tutto di te, vuol dire che non sei uno di quei centomila che hanno dato a un’azienda privata tutti i loro dati genetici e medici. I servizi di 23andMe sono tutti online, ti spediscono a casa il tampone, glielo rimandi dopo averlo insalivato per bene e loro ti sequenziano il genoma. O meglio, una serie di diverse centinaia di Snp, piccole mutazioni correlate con malattie ereditarie. Vuoi sapere quanto rischi di ammalarti di diabete? 23andMe te lo dice. Vuoi sapere se hai un antenato irlandese? Ecco la risposta, scritta nei tuoi geni.
Centomila. Sono arrivati a centomila i clienti di 23andMe, l’azienda di genomica personalizzata di Google che da qualche anno si è messa sul mercato della genetica fai-da-te. Se sei preoccupato perché Facebook e Google sanno tutto di te, vuol dire che non sei uno di quei centomila che hanno dato a un’azienda privata tutti i loro dati genetici e medici. I servizi di 23andMe sono tutti online, ti spediscono a casa il tampone, glielo rimandi dopo averlo insalivato per bene e loro ti sequenziano il genoma. O meglio, una serie di diverse centinaia di Snp, piccole mutazioni correlate con malattie ereditarie. Vuoi sapere quanto rischi di ammalarti di diabete? 23andMe te lo dice. Vuoi sapere se hai un antenato irlandese? Ecco la risposta, scritta nei tuoi geni.
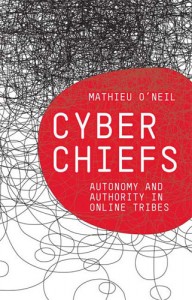 Ecco la versione italiana di una mia recensione appena pubblicata da New Media and Society.
Ecco la versione italiana di una mia recensione appena pubblicata da New Media and Society.
La lunga lotta tra la repubblica della libertà e il regno della burocrazia si è spostata su internet. Cyberchiefs. Autonomy and Authority in Online Tribes di Mathieu O’Neil (Pluto Press 2009) è uno dei primi tentativi di analisi sociologica delle strutture di potere del web in relazione alla celebrata autonomia che la rete darebbe ai suoi utenti. L’autore si concentra sulla relazione tra la ricerca di autonomia e i processi reali che regolano la produzione diffusa e orizzontale di contenuti che avviene in progetti come quelli di free software o nella blogosfera – esempi ben noti di un nuovo tipo di sistema produttivo reso possibile dal web collaborativo, o web 2.0. O’Neil propone di definire una nuova forma istituzionale che lui chiama burocrazia tribale online e che è peculiare di internet e diversa dalle forme di organizzazione precedenti.
Sono in missione per conto di San Precario. E Precarifornia è il mio nuovo Twitter per raccogliere notizie e commenti su lavoro, movimenti e (contro)culture da Los Angeles.

Il nuovo numero della rivista australiana Fibreculture è tutto dedicato a teoria critica e web 2.0. Il sottotitolo dice "before, during and after the event", perché la nascita e l’emergere della rete collaborativa è un processo ancora in atto ma i cui contorni sono già stati tracciati da un fiume in piena di libri, post e talk a congressi. Uno degli articoli più interessanti di questo numero di Fibreculture è Beyond the ‘Networked Public Sphere’ di Ben Roberts, che analizza l’utopia tecnocratica del web come forma di partecipazione di per sé migliore, più aperta, più democratica. Criticando Yochai Benkler, Roberts afferma che le istanze di partecipazione non possono basarsi solo sull’uso di uno strumento tecnologico, ma devono far parte di un progetto politico-economico ben più ampio.
In questo senso è interessante anche il breve saggio di Michel Bauwens, Co-creation and the new industrial paradigm of peer production, che magari non aggiunge molto di nuovo a chi già conosce la sua visione del peer-to-peer come dinamica sociale e non solo tecnologica, ma ha il pregio di racchiudere in poco spazio le sue tesi principali. Infine c’è anche il collettivo Ippolita, che con Geert Lovink e Ned Rossiter firma The Digital Given: 10 Web 2.0 Theses.
 Ecco la versione estesa dell’intervista che io e Espanz
Ecco la versione estesa dell’intervista che io e Espanz
abbiamo fatto a Michel Bauwens, che esce oggi sul
manifesto in un paginone di Chip&Salsa tutto dedicato all’open
source. Se non vi basta, qui potete leggere il suo saggio The Political Economy of Peer Production. Potete anche scaricare l’mp3 con l’audio del suo intervento a Milano qualche settimana fa.
Molti sono alla ricerca di un nuovo paradigma economico e sociale che prenda il sopravvento nel 21mo secolo. Michel Bauwens lo ha individuato nel peer to peer. E non parliamo solo di sistemi per scambiarsi file su internet, ma di un modo di produzione non gerarchico, decentrato e tra pari che esca da internet e contamini tutta la società. Bauwens, che insegna alla Dhurakij Pundit University di Bangkok, con la P2P Foundation si occupa di raccogliere e sistematizzare tutte le esperienze di cooperazione libera, tra pari, dal basso, open source. E’ l’evangelista del peer to peer.
Cosa intendi per P2P?
Tutti ormai usano programmi di file sharing peer to peer per scaricare video o musica. Ma l’uso che faccio io del termine è piu ampio e più profondo. Fondamentalmente in quei programmi ogni computer del sistema agisce come un pari tra altri pari. Non c’è un computer centrale da cui scaricate un film. Per me la caratteristica principale dei sistemi P2P è proprio la possibilità che danno agli individui di entrare liberamente in relazione con gli altri e di agire insieme. Possiamo chiamarlo network distribuito e decentrato, in cui il potere è spezzettato e diviso tra tutti. Pensate a un’autostrada, costruita da qualcuno tramite una decisione dall’alto, e a un sentiero nel bosco, che è il risultato del passaggio di diverse persone. Il risultato è simile, ma il tipo di interazione tra le persone è completamente diverso. Internet può essere usato come un’infrastruttura orizzontale che permette alle persone di connettersi, creare media, condividere file, lavorare insieme: la rete abilita dinamiche P2P.
Come funzionano le comunità P2P?
Le comunità di produzione tra pari sono basate su dinamiche sociali particolari: se sei un programmatore di sofware libero o se scrivi su Wikipedia sei un volontario non pagato, ma sei spinto dalla tua passione e da una forte motivazione. Questo è il sogno delle imprese: lavoratori motivati. Be’, nel mondo P2P le persone non motivate sono automaticamente escluse, perché non hanno altri motivi per partecipare, e questo ne fa un ambiente straordinariamente produttivo. E poi nella produzione tra pari c’è un nuovo modo di guardare alle persone, che io chiamo equipotentiality. Invece di decidere un modo di produzione e poi assumere persone per portarlo a termine, devo disegnare un compito e dividerlo in pezzi più piccoli possibili. Poi serve un sistema che permetta alla gente di far coincidere le sue idee, le sue capacità, con i compiti da svolgere, proprio come fa Wikipedia. Il meccanismo è basato sull’autoselezione. Bisogna aprire al massimo la partecipazione e creare controlli di qualità di tipo comunitario, creando un sistema basato sull’inclusione e non sull’esclusione.
E’ così rivoluzionario?
Per me questo è un punto di svolta sociale nella nostra civiltà. Per semplificare lo scambio di informazioni e di beni abbiamo dato vita a società gerarchiche. Oggi le nuove infrastrutture tecnologiche permettono una coordinazione globale di piccoli gruppi. Quindi la novità è che possiamo creare artefatti sociali molto complessi, come Wikipedia o Linux, senza bisogno di un’organizzazione gerarchica in cui qualcuno dica agli altri cosa devono fare: una moltitudine di individui e gruppi si coordinano e controllano il loro lavoro. Un cambiamento in direzione di relazioni e strutture P2P. Credo che in questo ci sia un grande potenziale di liberazione che conduce verso alternative aperte, basate sui beni comuni e sulla partecipazione che sono legate al P2P, in cui le gerarchie sono flessibili e le strutture aperte alla partecipazione.
Quali processi sociali vi stanno alla base?
Parliamo di tre nuovi tipi di processi sociali che ora avvengono non su scala locale ma su scala globale. Il primo è la produzione tra pari, cioè la capacità di produrre valore comune. Il secondo è la governance P2P, cioè la capacità di gestire questi processi senza ricorrere a gerarchia e centralizzazione. Il terzo è la proprietà P2P, cioè la possibilità di proteggere i beni comuni e dei prodotti del lavoro comune dall’appropriazione privata. Se chiudo l’accesso a un bene dicendo che è mio e non più tuo, be’… in questo modo distruggo l’intera comunità P2P. Questo non significa che questi beni o informazioni non possano essere usate da un’azienda, per esempio, per mezzo di licenze come quelle che proteggono il software libero. Tutti possono usarlo purché non lo privatizzino e rilascino i loro prodotti nel dominio pubblico.
Non è un orizzonte così semplice da intravedere
Infatti dobbiamo aprire la nostra immaginazione politica e sociale: siamo abituati a pensare all’alternativa tra stato e mercato. Da una parte privatizzazione e liberismo, dall’altra l’intervento dei governi per salvare le banche, per esempio. La produzione P2P ci invita a guardare a un terzo modo di trovare soluzioni politiche, economiche o sociali che siano organizzate sui gruppi umani.
Secondo te il P2P rimarrà limitato a nicchie di produzione o si espanderà?
La storia del capitalismo è fatta di grandi ondate di crescita basate su tecnologie rivoluzionarie. Ciclicamente, il capitalismo si trova di fronte a una crisi, e da queste crisi il mondo esce cambiato. Credo che ora stiamo andando verso qualcosa di simile: il mondo fondato sul sistema di produzione industriale sta crollando e non sappiamo cosa troveremo al suo posto. Probabilmente però le nuove tecnologie su cui si baserà il sistema futuro saranno il web e le tecnologie dell’informazione; esse stanno già crescendo alle periferie del sistema industriale. Il modello futuro dovrà includere l’apertura alla partecipazione e alla produzione peer to peer, proprio come il capitalismo di oggi ha dovuto inglobare le idee socialiste con il welfare e il suffragio universale, per esempio.
Quali sono le misure che proponi?
Dobbiamo favorire l’apertura delle infrastrutture, ovviamente. Ma abbiamo bisogno anche di tre tipi di istituzioni: la prima sono i beni comuni, che vanno protetti finanziando l’innovazione sociale, per esempio ricercatori che producono nuovi farmaci e invece di brevettarli li mettono a disposizione di tutti. Poi dobbiamo favorire le pratiche economiche sostenibili: sostegno alle piccole imprese che fanno innovazione sociale, per esempio. Infine è necessario sostenere quell’1% di persone che sono più attive nella produzione P2P. Infatti il 90% circa degli utenti di progetti P2P ne fa un uso passivo, il 10% contribuisce saltuariamente, e l’1% invece è composto da persone che lavorano al progetto a fondo. Questo 1% deve poter sopravvivere senza fare altri lavori. Le città e le regioni che sapranno dar vita a queste tre istituzioni saranno più interessanti per le comunità P2P ma anche per il business: saranno economicamente più forti.
Nessuno, però, ha ancora trovato il modo per difendere i diritti di chi produce contenuti gratuiti per il web
Per questo dobbiamo accelerare questo processo e favorire le domande sociali che spingono per il peer to peer, l’open access, i beni comuni. Già oggi in fondo assistiamo alla nascita di un welfare dal basso basato su beni comuni e P2P: ci sono comunità che vengono sostenute da aziende per portare avanti progetti P2P, per esempio quella del software open source. Ciò però non garantisce i singoli individui: c’è bisogno di un reddito di base per tutti, che permetta di affrontare i periodi di transizione da un lavoro all’altro o quelli in cui si passa dal mercato alla produzione P2P. Dopo la seconda guerra mondiale l’idea di un welfare universale sembrava un’utopia. Eppure l’abbiamo ottenuto. Anche oggi dobbiamo contemplare riforme radicali.
 Sul Manifesto di oggi, un’intervista a Clay Shirky, autore di Uno per uno, tutti per tutti. Il potere di organizzare senza organizzazione (Codice edizioni, 250 pagine, 23 euro)
Sul Manifesto di oggi, un’intervista a Clay Shirky, autore di Uno per uno, tutti per tutti. Il potere di organizzare senza organizzazione (Codice edizioni, 250 pagine, 23 euro)
Ormai è un luogo comune: il nuovo ecosistema di media che usiamo per collaborare online – wiki, blog, social network, e chi più ne ha più ne metta – sta cambiando il modo di produrre sapere e conoscenza, di aggregare cultura, di fare società e perché no anche di produrre merci. Un intero filone di studiosi e tecnologi liberali, in gran parte nordamericani, insiste da anni sul contenuto intrinseco di democratizzazione di questi nuovi strumenti che permettono a chiunque disponga di un computer e di una connessione internet di partecipare al dibattito pubblico o di aggregarsi a progetti collettivi.
Il nuovo libro di Clay Shirky si concentra in particolare, come dice il sottotitolo, sulla possibilità di aggregare forze collettive senza bisogno di una delle classiche forme di organizzazione gerarchica che conosciamo nel mondo offline: partiti, associazioni, istituzioni. Nella pagine del Chip&Salsa di oggi trovate un sacco di esempi di organizzazioni dal basso, nate nella rete ma che hanno avuto un effetto sensibile sulle vite delle persone, sulla loro capacità di incidere sul mondo.
Tuttavia, Shirky non si schiera completamente con gli entusiasti a tutti i costi. Infatti il rapporto tra la massa degli utenti delle piattaforme di cooperazione online e le istituzioni classiche non è poi così indolore come alcuni lo rappresentano. Il web viene usato anche in modo gerarchico, i suoi utenti sfruttati per raggiungere uno scopo deciso dall’alto, e le forme organizzative democratiche possono venirne colpite. Gli abbiamo chiesto proprio di spiegarci meglio i punti deboli del web come strumento di organizzazione.
Sottolinei come le nuove forme di cooperazione online siano un cambiamento sociale importante prodotto dalle tecnologie del web. Ma non dovremmo concentrarci su quello per cui collaboriamo? Le tecnologie sono vuote se non pensiamo ai valori e ai poteri che le muovono.
Ci vuole un sacco di tempo per capire come usare le nuove tecnologie. Prendiamo le forme di stampa come i giornali o i romanzi come se fossero cose garantite, assodate, ma entrambe queste forme di comunicazione sono state inventate, e sono state inventate da persone che non sapevano quello che stavano facendo. Chiedere che ci concentriamo sugli usi finali di uno strumento che è ancora all’inizio della sua vita è una ricetta per non fare altro che copiare le vecchie modalità e contenuti nel nuovo media. Il modo per far sì che il web funzioni è usarlo per tutte le cose che vogliamo, siano serie o stupide, fino a quando non capiremo cosa funziona e cosa no.
Qual è la relazione tra cooperazione e istituzioni? Molti critici dicono che istituzioni come le imprese o i partiti politici stanno sfruttando le istanze di partecipazione sulla rete per raggiungere i loro obiettivi economici o politici.
Certo, ma questo è vero anche per la stampa, la tv o la radio. È vero per i libri e per le riviste. È vero per i media in generale. La gente usa gli altri per ogni tipo di cose e obiettivi, e gli scontri cui abbiamo assistito e stiamo assistendo all’interno della rete sono un po’ più turbolenti e democratici di quelli che vediamo per esempio nei giornali, dove i lettori non possono rispondere. Anzi, non possono nemmeno parlarsi l’un l’altro.
I processi di democratizzazione sono abbastanza forti da resistere a questo tipo di appropriazione del loro valore?
Credo di sì… nemmeno le nostre attuali culture democratiche hanno resistito completamente a questa appropriazione, ma molte restano in buona salute. Questa è proprio la stessa sfida, che si ripete in forme diverse e nuove ma stavolta avendo a disposizione un media calibrato molto meglio sulle conversazione tra cittadini rispetto a qualsiasi altro media che abbiamo usato nella storia.
Ecco, secondo te questi processi che avvengono sui media sono indipendenti dai processi di democrazia che avvengono nel mondo? Insomma, esiste il cambiamento sociale online senza un cambiamento nella vita “reale”?
Come diceva Wittgenstein, “Il mondo è tutto ciò che accade”. Una delle cose che sono reali nel mondo reale è proprio internet: è una questione di ibridazione. Per fare un esempio italiano, il movimento Addio Pizzo, che lotta contro il pagamento del pizzo alle mafie, è in parte mediato e in parte agisce nel mondo fisico, e sarebbe meno efficace se una di queste metà non ci fosse.
Qual è la differenza tra condivisione e collaborazione?Credi che la collaborazione stia crescendo anche al di fuori dei campi in cui abbiamo già assistito alla sua crescita, come il web?
Succede sempre più spesso che semplici forme di condivisione portino a forme molto più complesse di collaborazione. Per fare un esempio, i 40.000 studenti delle superiori che hanno fatto una manifestazione politica a Los Angeles si conoscevano tutti a vicenda grazie a MySpace. Hanno cominciato condividendo musica e gossip, e sono arrivati ad attivarsi diventando un movimento politico. E sì, certo, questo schema si sta riproducendo ovunque ci siano dei gruppi che si mettono insieme per fare delle cose.
Quali sono i passi da fare per costruire una comunità reale partendo da uno strumento tecnico come un sito web? Possiamo riconoscere dei segni che ci dicono che quella comunità sta diventando un vero movimento organizzato?
Non c’è una ricetta. Le cose che hanno funzionato in una comunità potenziale falliranno in un altro caso, dato che gli strumenti da soli non sono abbastanza per creare cultura. Possiamo dire che una comunità si sta formando quando i suoi membri cominciano a litigare tra di loro, e che è del tutto formata quando la gente comincia a minacciare di andarsene.
Credi che le reti senza organizzazione non sviluppino strutture gerarchiche? In un vecchio saggio hai parlato di ineguaglianza nei blog e nei forum.
Spesso sviluppano strutture gerarchiche. Il vero cambiamento è che non sviluppano strutture “manageriali”. Per esempio, Guido van Rossum è il leader universalmente riconosciuto del linguaggio di programmazione Python, che è stato creato da lui. Infatti, il suo titolo all’interno della comunità di programmatori è BDFL, Benevolent Dictator For Life (dittatore benevolo a vita)
Tuttavia, dato che Python è un progetto open source, gli sviluppatori che lo migliorano non lavorano per lui. Se dovesse diventare tirannico, che so, oppure insistere su u piano di azione che danneggerebbe Python, quegli stessi programmatori sono liberi di prendere tutto il loro lavoro e riutilizzarlo ovunque senza di lui. Quindi qui c’è gerarchia, ma è un tipo di gerarchia che richiede un grado di rispetto reciproco più i classici contratti di lavoro.
Senza strumenti organizzati, il cyberpopulismo può prevalere. Questa è una classica critica contro il web collaborativo, cosa ne pensi?
Come scrivo nel libro, non si tratta di un semplice rimpiazzamento. Le organizzazioni restano essenziali per diversi motivi. Piuttosto, le organizzazioni hanno perduto il loro monopolio sull’azione organizzata; ma in luoghi dove svolgono meglio queste funzioni, come per esempio gestire un ospedale, continueranno a farlo. In casi in cui un gruppo di persone può fare cose senza gerarchie e organizzazioni, come nel caso della creazione di Wikipedia, potranno farle.
In generale mi sembra che gli orrori del populismo siano presenti in modo più vivido nelle elite politiche che vogliono mantenere un alto livello di privilegi. Dovremmo preferire forme di azione più rappresentative.
Gli esempi che fai nel libro sembrano molto efficacy nel produrre critiche e proteste. Ma sono utili anche per produrre nuove idee? Non c’è un gap tra la rete come strumento organizzativo e come luogo per creare nuove idee?
Questo per me potrebbe essere il prossimo grande cambiamento. Gran parte delle azioni del mondo reale che vengono coordinate con i social media oggi vanno nella direzione della protesta a breve termine, mentre nel campo della creazione di contenuti abbiamo enorme creatività a lungo termine per mano di gruppi giganteschi (per esempio Python o Linux).
Parte della differenza sta nel fatto che la gente che crea contenuti è aiutata dall’open source e dalle licenza Creative Commons. Io credo che vedremo un sacco di sperimentazione con “licenze per l’azione collettiva”, che saranno forme alternative di incorporare i contenuti. In questo modo avremo forme di associazione native della rete che si sposteranno dal modello “aggregatore di critiche” verso forme a lungo termine e più costruttive di lavorare in modo cooperativo.
È questo il trend principale che vedi per il futuro?
Il trend più importante è che non c’è alcun trend principale. Quando la gente pensa al futuro, spesso pensa che sarà concettualmente più semplice del presente. Ma questo non accade mai.
Giovedì 19 marzo alle 17 a Milano, facoltà di Scienze politiche, potete sentire Michel Bauwens della P2P Foundation che parlerà di peer to peer, produzione dal basso e innovazione nella produzione di conoscenza.

 Come si fa a disgiungere l’Onda, e più in generale i movimenti sociali degli anni 2000, dall’uso del web? Sarebbe come pensare al maggio francese senza i manifesti serigrafati o le scritte sui muri. Da Indymedia ai blog degli studenti in mobilitazione, siamo ormai abituati a leggere e produrre notizie e punti di vista, e a discutere con gli altri su Internet. Nel corso degli ultimi anni articoli, libri, ricerche sul ruolo della rete nei nuovi movimenti si sono sprecati.
Come si fa a disgiungere l’Onda, e più in generale i movimenti sociali degli anni 2000, dall’uso del web? Sarebbe come pensare al maggio francese senza i manifesti serigrafati o le scritte sui muri. Da Indymedia ai blog degli studenti in mobilitazione, siamo ormai abituati a leggere e produrre notizie e punti di vista, e a discutere con gli altri su Internet. Nel corso degli ultimi anni articoli, libri, ricerche sul ruolo della rete nei nuovi movimenti si sono sprecati.
Ma sono i media a determinare i movimenti? Che ruolo hanno quindi i blog, Facebook, YouTube e gli altri media collaborativi, cioè quelli che chiunque può produrre gratuitamente dal computer di casa? L’ho chiesto ad Adam Arvidsson, un sociologo che da Copenhagen è arrivato da poco alla Statale di Milano. Arvidsson si occupa di media digitali e comunicazione ma anche del ruolo dei brand nella cultura dei consumi.
La protesta corre sulla rete?
I media che troviamo sul web non sono altro che i media che sono entrati nella pratica quotidiana della nostra generazione, quindi usare Facebook non è poi diverso da usare il telefono: il tempo del feticismo della rete è passato. Non penso che l’uso di internet cambi di molto le dinamiche della protesta. Ovviamente è utile per mobilitare e diffondere informazioni in modo più efficiente del classico volantinaggio, ma non causa cambiamenti radicali.
E questo movimento usa media commerciali invece di produrre i suoi stessi media, come si fece con Indymedia qualche anno fa.
Non so se usare piattaforme commerciali o meno sia molto differente. In fondo le aziende del web 2.0 hanno costruito delle proprietà immobiliari virtuali. Tu crei una piattaforma, per esempio MySpace, che è stata venduta a Murdoch nel 2005 per miliardi e miliardi dollari, genera un cash flow di pubblicità di 16 miliardi di dollari all’anno. Ma questa pubblicità acquista valore in quanto entra nei flussi di comunicazione… si tratta di disturbare un minimo questi flussi di comunicazione per inserire spazi pubblicitari, ma ciò non influisce troppo sull’uso dei media.
 Mentre scrivo il mio pc sta scaricando un tot di film e dischi piratati. Sono un criminale o sto fruendo cultura nel modo proprio del nostro tempo? Un criminale, secondo Denis Olivennes, ex-direttore della megacatena di distribuzione di dischi Fnac in Francia e consulente del governo Sarkozy in materia. Ribaltando il celebre motto di Proudhon, “La proprietà è un furto”, il suo libro si intitola La gratuità è un furto. Quando la pirateria uccide la cultura (Libri Scheiwiller, 128 pagine, 14 euro).
Mentre scrivo il mio pc sta scaricando un tot di film e dischi piratati. Sono un criminale o sto fruendo cultura nel modo proprio del nostro tempo? Un criminale, secondo Denis Olivennes, ex-direttore della megacatena di distribuzione di dischi Fnac in Francia e consulente del governo Sarkozy in materia. Ribaltando il celebre motto di Proudhon, “La proprietà è un furto”, il suo libro si intitola La gratuità è un furto. Quando la pirateria uccide la cultura (Libri Scheiwiller, 128 pagine, 14 euro).
L’autore sostiene che l’anarchia di internet finirà col ridurre la diversità culturale, togliendo ossigeno agli autori che non si uniformano al mainstream delle major. È il rischio della “scomparsa pura e semplice delle opere, in conseguenza di mancati guadagni da parte di creatori e produttori”.